|
Prof.
Andrea Saccoman
L’11 agosto 1916 le prime truppe del Corpo
di Spedizione Italiano in Macedonia sbarcarono nel porto di Salonicco
per unirsi all’Armata Francese d’Oriente (comprendente
anche unità britanniche e serbe).
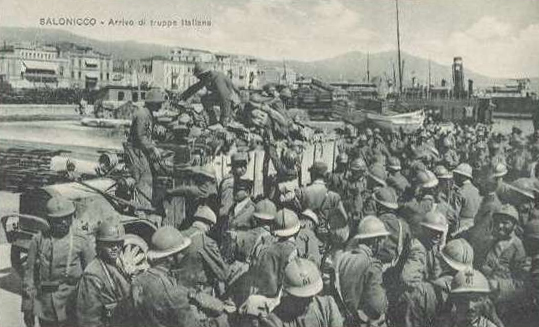
Truppe italiane sbarcano a Salonicco
La scelta di inviare truppe sul fronte della
Macedonia a combattere gomito a gomito con francesi e inglesi
fu legata all’intento del governo italiano di migliorare
i rapporti con gli alleati.
Persino Cadorna si mostrò sulle prime favorevole, poiché
riteneva che un’offensiva lungo la valle del fiume Vardar
fosse promettente.
Per il contributo italiano fu prescelta la 35a Divisione, comandata
dal Generale Carlo Petitti di Roreto, che si imbarcò a
Taranto con il primo scaglione l’8 agosto 1916.
Ai primi di settembre, completati gli arrivi, la formazione della
grande unità era la seguente:
Brigata Cagliari (63° e 64° Reggimento Fanteria, 228a
e 229a compagnia mitragliatrici);
Brigata Sicilia (61° e 62° Reggimento Fanteria, ogni battaglione
dei due reggimenti comprendeva due sezioni mitragliatrici e una
sezione pistole mitragliatrici);
Uno Squadrone del Reggimento Cavalleggeri di Lucca (16°);
Raggruppamento di artiglieria da montagna su quattro gruppi di
due batterie su quattro pezzi da 65/13;
XXIII Battaglione Genio su tre compagnie; oltre a reparti minori
e ai servizi, per un totale di 731 ufficiali, 25.099 uomini di
truppa, 5582 quadrupedi.
Il 19 ottobre 1916 la Divisione fu rinforzata con l’arrivò
della Brigata Ivrea (161° e 162° Reggimento Fanteria,
con due compagnie mitragliatrici) e un secondo squadrone di cavalleria.
La divisione fu schierata inizialmente sulla catena montuosa del
Krusa Balkan incuneata tra le truppe inglesi. Pur non partecipando
ad azioni di rilievo, alla fine di novembre la divisione aveva
perduto 12 ufficiali e 462 uomini di truppa tra morti, feriti
e dispersi o prigionieri. A causa della malaria e altre malattie
aveva perduto ben 5000 uomini.
Nel dicembre 1916 la divisione fu trasferita nel settore dell’ansa
del fiume Cerna, circa 130 chilometri ad ovest in linea d’aria,
ma circa 200 di marcia su strade disagevoli.
Il 31 dicembre 1916 il Generale Petitti assumeva il comando del
settore Cerna-Makovo, dove la divisione avrebbe operato fin quasi
al termine della guerra. Il 6 maggio 1917 la divisione passò
al comando del generale Giuseppe Pennella, che lo tenne solo fino
al 16 giugno successivo, quando gli subentrò il generale
Ernesto Mombelli che lo tenne fino alla fine della guerra.
Era una zona priva di vegetazione e di appigli naturali, paludosa
e malsana nella parte bassa, aspra e priva di ogni comodità
in quella montana. Il clima era torrido d’estate e glaciale
d’inverno. Il nemico dominava la linea del fronte dall’alto
delle vette e poteva riversare su di essa il fuoco delle sue artiglierie,
talvolta con l’uso di aggressivi chimici.
Si ripeterono anche qui gli scenari della guerra di posizione,
con l’aggravante che la distanza dall’Italia e l’insufficienza
dei mezzi di trasporto impedirono a molti militari di usufruire
delle licenze alle quali avevano diritto. Alla fine vi furono
oltre 6000 soldati che contavano oltre 26 mesi di ininterrotta
permanenza in linea, altrettanti con oltre 15 mesi, e 18000 che
non tornavano a casa da più di un anno. Gli stessi problemi
resero anche irregolare il servizio postale. E ciononostante i
soldati italiani sopportarono gli inconvenienti e i disagi con
encomibile stoicismo. Circondati da un alone quasi leggendario
divennero i combattimenti per la conquista delle posizioni di
quota 1050 e del Piton Brûlé, che nulla ebbero da
invidiare, nel bene e nel male, con quelli sull’Isonzo,
sul Carso o sugli Altipiani.
 Il 14 settembre 1918, con la preparazione d’artiglieria,
ebbe inizio la grande offensiva alleata sul fronte macedone. Il
15 settembre le truppe francesi e serbe sfondavano il fronte nemico,
oramai tenuto quasi esclusivamente da truppe bulgare, avendo tedeschi
e austro-ungarici ritirato gran parte delle loro per le offensive
in occidente. La 35a divisione italiana collaborò dapprima
con azioni dimostrative e poi, dopo aver respinto un attacco nemico
il 21 settembre, cominciando ad avanzare decisamente anch’essa.
Gli italiani si impadronirono quindi del poderoso sistema montuoso
per il quale era stato versato nell’anno e mezzo precedente
tanto sangue con pochissimi risultati.
Il 14 settembre 1918, con la preparazione d’artiglieria,
ebbe inizio la grande offensiva alleata sul fronte macedone. Il
15 settembre le truppe francesi e serbe sfondavano il fronte nemico,
oramai tenuto quasi esclusivamente da truppe bulgare, avendo tedeschi
e austro-ungarici ritirato gran parte delle loro per le offensive
in occidente. La 35a divisione italiana collaborò dapprima
con azioni dimostrative e poi, dopo aver respinto un attacco nemico
il 21 settembre, cominciando ad avanzare decisamente anch’essa.
Gli italiani si impadronirono quindi del poderoso sistema montuoso
per il quale era stato versato nell’anno e mezzo precedente
tanto sangue con pochissimi risultati.
I Cavalleggeri di Lucca insieme a gruppi di mitragliatrici su
autocarri venivano lanciati all’inseguimento. Era aperta
la strada per la conquista della città di Prilep, ma il
comando francese fece deviare verso ovest i reparti italiani per
tagliare la strada alle forze nemiche che si ritiravano dal fronte
di Monastir (oggi Bitola in Macedonia). L’ottimo comportamento
delle truppe italiane permise di superare tutte le resistenze
e di partecipare efficacemente alla manovra generale. Mentre gli
italiani si accingevano ad attaccare le posizioni della città
di Sop, alle 5,30 antimeridiane del 30 settembre 1918 il generale
Mombelli riceveva via radiotelegramma l’avviso che la Bulgaria
aveva firmato l’armistizio. Il 3 ottobre furono quindi fatti
prigionieri un generale di divisione e due di brigata, 16 ufficiali
superiori, 234 inferiori e 7727 uomini di truppa bulgari. Furono
catturati 8 cannoni, 70 mitragliatrici e molto materiale.
Le unità dell’Intesa poterono così dilagare
nei Balcani e il 31 ottobre 1918 il Quartier Generale della 35a
Divisione si installava in territorio bulgaro, dove le truppe
italiane rimasero quale forza di occupazione fino all’estate
del 1919. Il 7 febbraio 1919, per desiderio del Governo italiano,
il III Battaglione del 62° Reggimento Fanteria sbarcava a
Istanbul, seguito in aprile dal comando del reggimento.
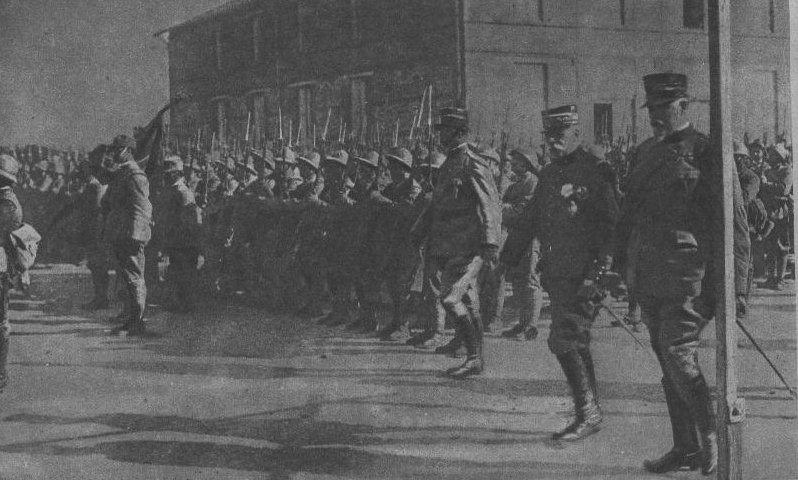
Truppe italiane a Salonicco
Alla fine di luglio del 1919, da Salonicco, dove
aveva cominciato la sua avventura, il Corpo di spedizione italiano
in Oriente (come ora era stata chiamata la vecchia 35a Divisione)
si imbarcava per tornare in Italia e veniva sciolto ufficialmente
alle ore 24 del 31 luglio 1919.
Rimaneva soltanto il Comando del 62° Reggimento Fanteria con
due battaglioni a Istanbul e un battaglione in Dobrugia.
|