|
Prof.
Andrea Saccoman
Il 26 aprile 1915 l’Italia aveva firmato
il cosiddetto “Patto di Londra” ovvero lo strumento
diplomatico con il quale si vincolava a entrare in guerra entro
un mese a fianco di Inghilterra, Francia e Russia, l’alleanza
comunemente nota come Triplice Intesa.
L’articolo due del Patto prevedeva che l’Italia si
impegnasse ad impiegare la totalità delle sue risorse nel
perseguire la guerra in comune con la Francia, la Gran Bretagna
e la Russia contro tutti i loro nemici.
Seppure i nemici non erano indicati per nome, “tutti”
era parola abbastanza inequivoca. E in quel momento la Triplice
Intesa era in guerra con Germania, Austria-Ungheria e Impero Ottomano.
Tutti sanno che l’Italia, il 23 maggio 1915, dichiarò
guerra alla sola Austria-Ungheria. Nella serata del 24 maggio
la Germania ruppe le relazioni diplomatiche con l’Italia.
Sin dal 21 maggio, però, era stato sottoscritto a Berlino
un documento segreto sul trattamento dei sudditi italiani e germanici
e dei loro averi durante un eventuale stato di guerra. Germania
e Italia si garantivano reciprocamente la protezione dei propri
sudditi, malgrado la guerra e malgrado la rottura delle relazioni.
Persino la dichiarazione di guerra alla Turchia, o Impero Ottomano
che dir si voglia, che pure sarebbe dovuta essere più facile,
dato che la Turchia stessa aveva in parte contravvenuto al trattato
di pace firmato nell’ottobre 1912, arrivò dopo qualche
tergiversazione, il 21 agosto 1915. Dopo l’aggressione bulgara
alla Serbia, il 19 ottobre 1915 l’Italia dichiarò
“esistere stato di guerra fra Italia e Bulgaria”.
Gli atteggiamenti ambigui del governo Salandra resero i rapporti
con gli Alleati dell’Intesa tutt’altro che lineari:
l’idea del governo italiano era quella di combattere la
“nostra” guerra, quella del “sacro egoismo”,
come Salandra stesso aveva detto già il 18 ottobre 1914
nell’assumere l’interim del Ministero degli Esteri
dopo la morte del marchese Antonino di San Giuliano.
La storia della guerra italiana non è soltanto quella della
guerra combattuta contro i nemici al fronte, non è soltanto
la storia del fronte interno e della vita quotidiana dei soldati
al fronte e dei cittadini italiani nelle retrovie, ma anche la
storia dei rapporti con il Regno Unito, la Francia e la Russia.
Rapporti mai lineari, con accordi segreti da una parte e dall’altra
che violavano lo spirito e talvolta anche la lettera dei trattati
già sottoscritti. In ogni caso, sin dal maggio 1915 gli
Alleati fecero pressioni sull’Italia affinché adempisse
fino in fondo agli obblighi presi con il Patto di Londra.
Un mutamento importante in questo senso fu la caduta di Salandra
e l’insediamento del Governo Boselli. Sul piano politico-parlamentare
questo era un governo debole, con un Presidente del Consiglio
in età avanzata (78 anni compiuti) e con deputati e ministri
tenuti insieme soprattutto dallo scopo comune della vittoria ma,
per il resto, appartenenti a forze politiche troppo diverse fra
loro per dare affidamento di una coesione inattaccabile.
In sostanza, però, cercando di non scontentare nessuno,
il Governo Boselli finì per essere più disponibile
all’idea di dichiarare guerra a quello che tutti consideravano
il nemico più pericoloso dell’Intesa, ovverossia
la Germania.
La ripulsa della Strafexpedition e la conquista di Gorizia lasciarono
credere che la vittoria potesse essere più vicina di quanto
poi fu e in ogni caso migliorarono la posizione italiana sia sul
piano militare che su quello diplomatico.
E così, finalmente, il 27 agosto 1916
arrivò la dichiarazione di guerra alla Germania:
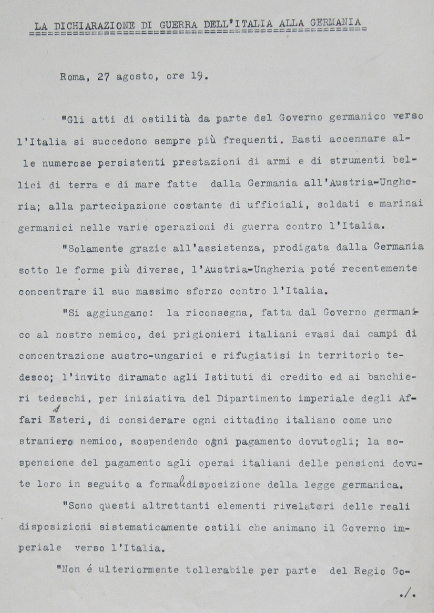
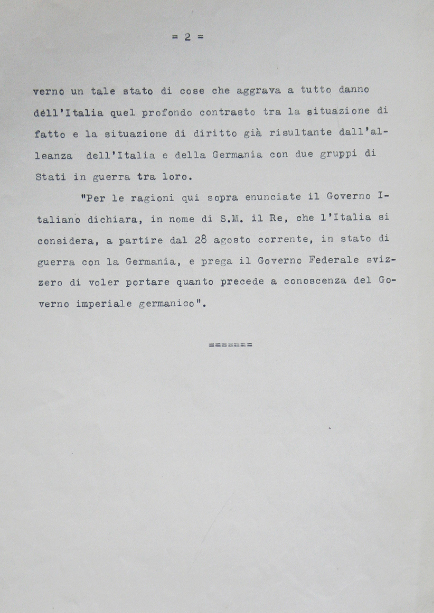
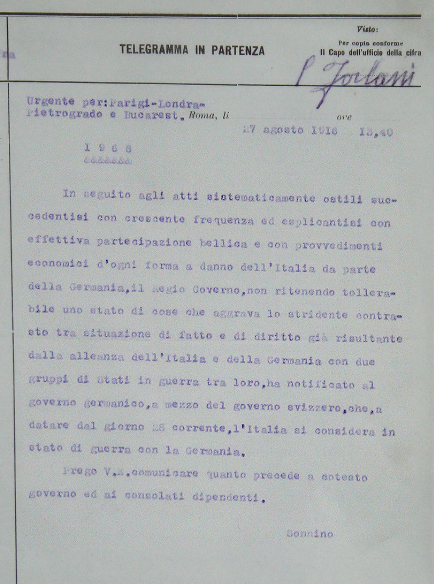
|